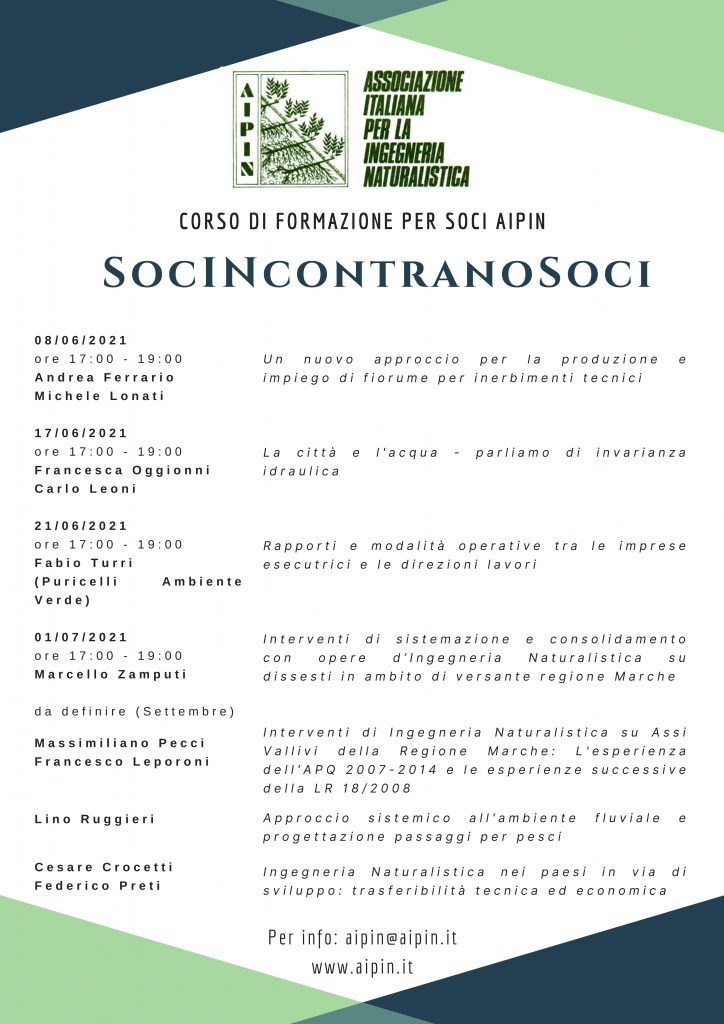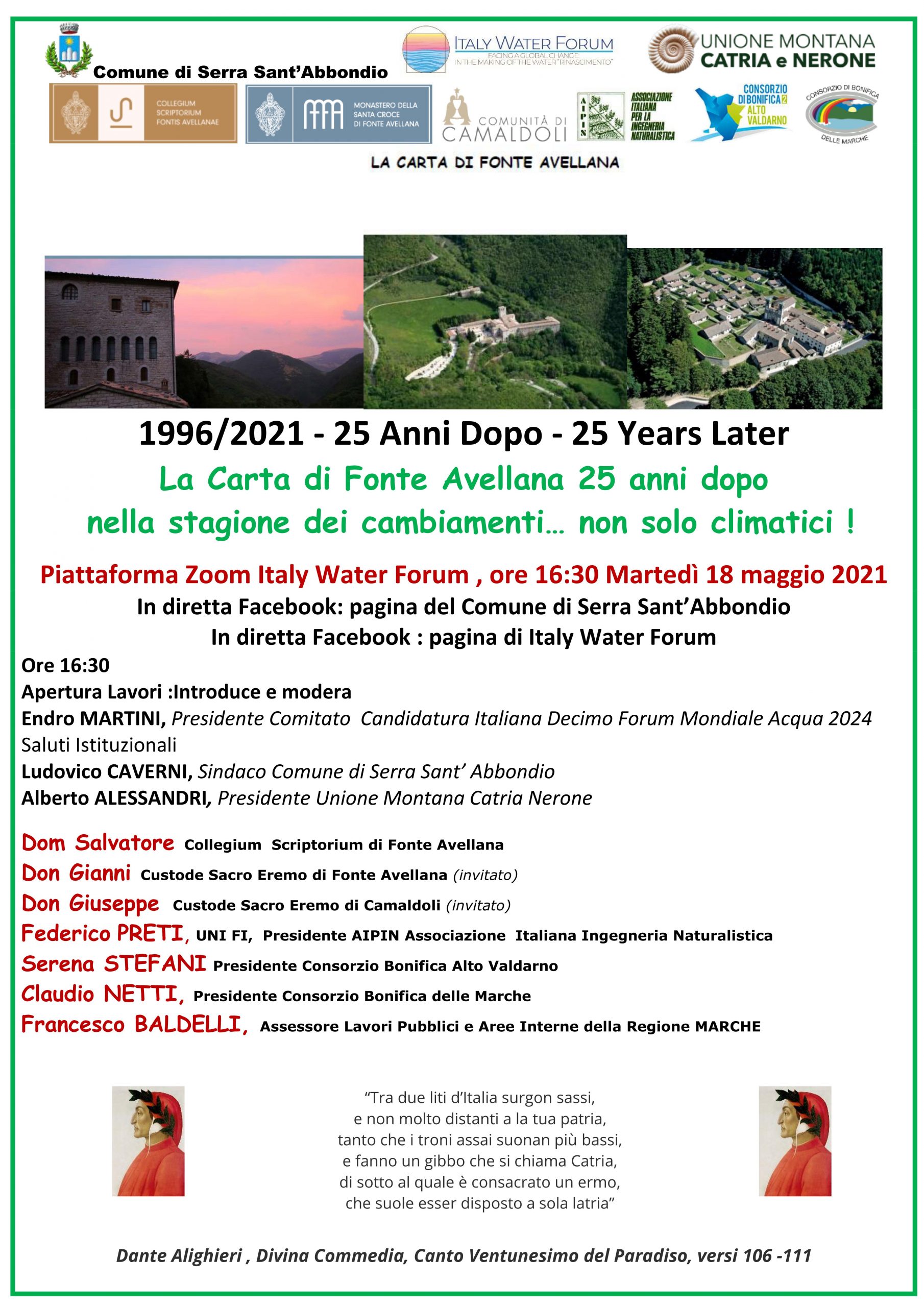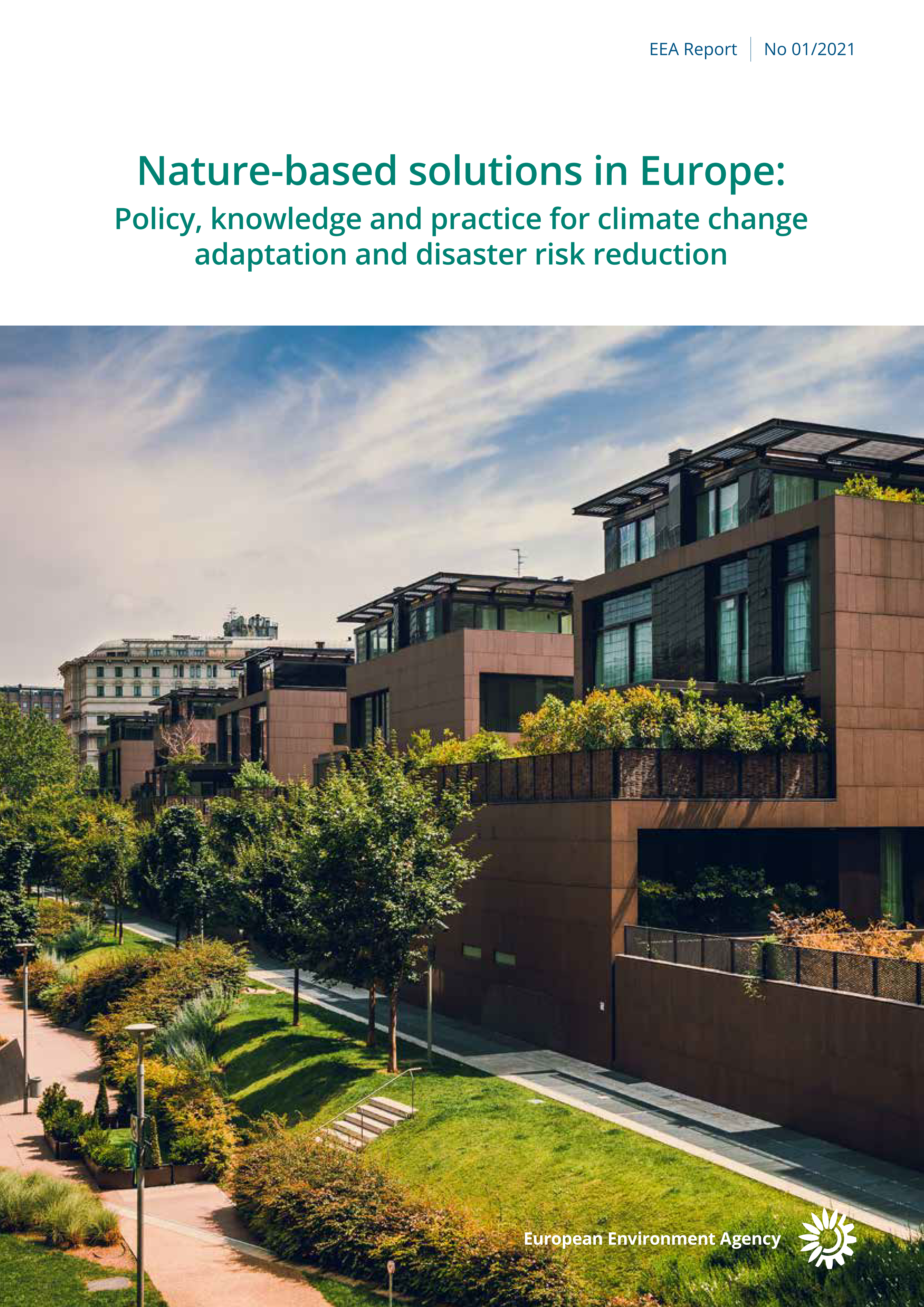Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia (2021)
Restoration ecology attraverso le Nature-based solution (NbS) e l’Ingegneria Naturalistica
Obiettivi della rinaturazione sono il ripristino di caratteristiche ambientali (riqualificazione di un bosco di una zona umida, reintroduzioni di specie, interventi su habitat o specie rare, azioni di contenimento di specie alloctone infestanti) o della funzionalità ecologica (capacità di esondazione e autodepurativa di un corso d’acqua, continuità ecologica, habitat per la biodiversità, fissazione di CO2 ecc.), di tutte quelle funzioni ecologiche cioè (soprattutto di regolazione), che in relazione alle necessità spesso vitali dell’uomo (domanda), diventano servizi ecosistemici. Tali prospettive di ricostruzione, inserite in quadri coerenti di relazioni spaziali, assumono la forma di vere e proprie reti ecologiche polivalenti, ove la natura coesista in modo ottimale con attività umane eco-compatibili che creano quella struttura di base utile a sviluppare infrastrutture verdi e blu. Purtroppo, l’uso umano del suolo domina gli ecosistemi della Terra e la massa antropica, in particolare strade ed edificato, raddoppiata all’incirca ogni 20 anni, nel 2020 ha superato tutta la biomassa vivente (Elhacham et al., 2020). Questa distruzione dell’ecosistema è tra le principali minacce alla biodiversità (Fischer e Lindenmayer, 2007) ed al funzionamento degli ecosistemi. Insieme ad altre strategie di conservazione, la restoration ecology rappresenta un mezzo per alleviare la crisi della biodiversità (Hobbs e Harris, 2001) e degli spazi ecosistemici. Le nostre capacità di ricreare gli ecosistemi semplicemente non sono – e potrebbero non essere mai – sufficienti a giustificare la distruzione degli habitat. D’altra parte, la protezione passiva di ecosistemi relitti, da sola, non sarà sufficiente a garantire la conservazione di un paesaggio e del suo Capitale Naturale. Dobbiamo renderci conto che non ci sono abbastanza ecosistemi che abbiano habitat adatti per la persistenza a lungo termine di molti taxa (Rodrigues et al., 2004). Il problema riguarda l’area minima vitale, gli spazi funzionali che dovremo rendere efficaci produttori di SE in modo da sviluppare un rapporto win-win fra attività antropiche ed ecosistemi e le biocenosi che li abitano. Certamente, dovremmo preservare ciò che rimane, ma il secolo attuale deve inoltre inaugurare un’era di restauro e recupero, in cui i territori che sono stati trasformati in ambienti distrofici, devono venire recuperate e modificate per supportare meglio la biodiversità e favorire le funzioni ecosistemiche di base (Hobbs e Harris, 2001) attraverso un approccio di cui le Nature-based solution (NbS) sono strumento chiave. Vi è un crescente riconoscimento delle opportunità di implementare le NbS, che impiegano e migliorano le proprietà e i servizi dell’ecosistema per fornire alternative sostenibili, convenienti, multiuso e flessibili per affrontare le sfide della società e l’adattamento ai cambiamenti climatici. La UE definisce le NbS come soluzioni ispirate e supportate dalla natura, che sono economicamente vantaggiose, forniscono contemporaneamente vantaggi ambientali, sociali ed economici e aiutano a costruire la resilienza; tali soluzioni portano sempre più natura e caratteristiche e processi naturali nelle città, nei paesaggi e nei paesaggi marini, attraverso interventi sistemici, efficienti sotto il profilo delle risorse e adattati a livello locale, considerando inoltre che le NbS devono avvantaggiare la biodiversità e supportare la fornitura di una gamma di servizi ecosistemici (Wild et al., 2020). L’obiettivo finale dell’ecologia del restauro deve essere prevedibile ripristinare gli ecosistemi a scala di paesaggio, la scala su cui viene gestita la biodiversità nella maggior parte dei paesi (Bestelmeyer et al., 2003). Il ripristino ecologico è ampiamente utilizzato per invertire il degrado ambientale causato dalle attività umane. Tuttavia, l’efficacia delle azioni di ripristino nell’aumentare la fornitura di biodiversità e servizi ecosistemici non è stata valutata 222 sistematicamente. Una meta-analisi di 89 valutazioni di ripristino in un’ampia gamma di tipi di ecosistemi in tutto il mondo indica che il ripristino ecologico ha aumentato la fornitura di biodiversità del 44% e di servizi ecosistemici del 25%; i valori di entrambi sono rimasti inferiori negli ecosistemi di riferimento ripristinati rispetto a quelli intatti. Gli aumenti della biodiversità e delle misure di servizi ecosistemici dopo il ripristino sono stati positivamente correlati. I risultati indicano che le azioni di ripristino incentrate sul miglioramento della biodiversità dovrebbero sostenere una maggiore fornitura di servizi ecosistemici (Benayas et al., 2009). Questi principi sono assolutamente validi anche in ambiente urbano, soprattutto riguardo l’approccio legato al metabolismo urbano (Musango et al., 2017) in cui le azioni sviluppate all’interno del decreto clima e in particolare nella Strategia nazionale del verde urbano (cfr par. 3.2.2) determinano un recupero funzionale e strutturale di aree ed ecosistemi degradati in una infrastruttura verde, dato che la Green Infrastructure Strategy è di fatto la Strategia europea che si collega direttamente alla richiesta di un più generale processo di recupero funzionale e strutturale degli ecosistemi degradati. Infine, rispetto agli interventi di recupero effettuati negli ultimi decenni al mondo della ricerca si chiede di passare da valutazioni qualitative a valutazioni quantitative in modo da definire interventi progettuali molto attenti alla tutela della biodiversità e quindi capaci di rispondere positivamente alla sempre maggiore domanda di servizi ecosistemici. Vista la complessità dell’oggetto d’analisi è auspicabile anche una metodologia di ricerca etnografica nei processi di restoration ecology in grado di mediare tra i risultati attesi, le politiche di progettazione territoriale e le aspettative comunitarie. La restoration ecology è un presupposto fondamentale per la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici e sarebbe dovuta essere stata promossa in modo strutturale già da anni a seguito della legge 133/2014, che prevede la realizzazione di “interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità”. La restoration ecology deve entrare nella prassi degli interventi a tutti i livelli di scala, perché mantenere funzionante un ecosistema o rendere ecologicamente funzionale un manufatto deve essere una priorità etica oltre che tecnica. Esistono approcci che condividono questa impostazione come l’Ingegneria Naturalistica, la Silvicoltura sostenibile, la Bioarchitettura in modo che le azioni e le tecniche siano sempre più permeate da un approccio ecosistemico.
Schede tipologico-progettuali di interventi di restoration ecology
A titolo esemplificativo, sono tati selezionati una serie di interventi grazie anche alla collaborazione dell’AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica) soprattutto in quegli ecosistemi che risultano critici e devono avere una priorità di ripristino evidenziata dalla Valutazione dello stato di conservazione degli ecosistemi (Blasi, 2020)
(Testo a cura di Riccardo Santolini)
Download Estratto iv_rapporto_cn_2021
In Allegato vi sono schede descrittiva degli interventi a cura di nostri soci e che applicano tecniche di SWB:
- Foce Torrente Acquicella (CT) Anno intervento: 2015
- Zone umide Bosco WWF di Vanzago SIC/ZPS IT2050006 Anno intervento: 2015-2019
- Frana di Pomezzana (Comune di Seravezza, LU) Anno 1997
- Rinaturazione Fiume Fella – Valbruna Anno intervento 1999
- Riqualificazione ecologico-paesaggistica di un torrente in area metropolitana milanese (Cesano Maderno, MI) anno 1996-2006
- Macchia Grande di Castel di Guido (Roma) Linea ferroviaria Roma- Maccarese Anno intervento 1988
- Risanamento della Pialassa della Baiona (Pola Longa, RA) attraverso la ricostruzione di dossi e barene per una migliore circolazione dell’acqua e disponibilità di habitat – Progetto Life 1994- 1995
- Comune di Sorso (SS) Lavori di risanamento e recupero ambientale del sistema dunale di Platamona 2007-2008
- Costruire natura con le infrastrutture grigie: lo scalo intermodale Hupac di Gallarate (VA)
Download Estratto Schede Soci AIPIN allegati_iv_rapporto_cn_2021
Link per scaricare il Quarto Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia (2021)